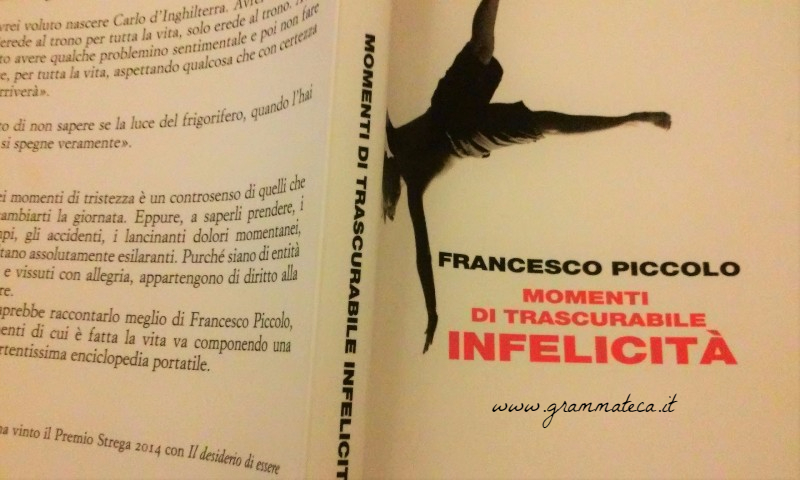Il 28 novembre 1907 nasceva Alberto Moravia.
Il Gramma-team lo ringrazia per i piacevoli momenti (di lettura) passati assieme e per le lezioni di vita apprese dai suoi racconti.
Qui di seguito, una lezione – da dare, da leggere o da scaricare – a tutti gli amanti im-perfetti.
Alberto Moravia, Non approfondire in Racconti Romani, 1954, Bompiani.
Agnese poteva avvertirmi invece di andarsene così, senza neppure dire: crepa. Non pretendo di essere perfetto e se lei mi avesse detto che cosa le mancava, avremmo potuto discuterne. Invece no: per due anni di matrimonio, non una parola; e poi, una mattina, approfittando di un momento che non c’ero, se ne è andata di soppiatto, proprio come fanno le serve che hanno trovato un posto migliore. Se ne è andata e, ancora adesso, dopo sei mesi che mi ha lasciato, non ho capito perché.
Quella mattina, dopo aver fatto la spesa al mercatino rionale (la spesa mi piace farla io: conosco i prezzi, so quello che voglio, mi piace contrattare e discutere, assaggiare e tastare, voglio sapere da quale bestia mi viene la bistecca, da quale cesta la mela), ero uscito di nuovo per comprare un metro e mezzo di frangia da cucire alla tenda, in sala da pranzo. Siccome non volevo spendere più che tanto, girai parecchio prima di trovare quello che faceva al caso mio, in un negozietto di via dell’Umiltà. Tornai a casa che erano le undici e venti, entrai in sala da pranzo per confrontare il colore della frangia con quello della tenda e subito vidi sulla tavola il calamaio, la penna e una lettera. A dire la verità, mi colpì soprattutto una macchia d’inchiostro, sul tappeto della tavola. Pensai: “Ma guarda come ha da essere sciattona… ha macchiato il tappeto”. Levai il calamaio, la penna e la lettera, presi il tappeto, andai in cucina e lì, fregando forte col limone, riuscii a togliere la macchia. Poi tornai in sala da pranzo, rimisi a posto il tappeto e, soltanto allora, mi ricordai della lettera. Era indirizzata a me: Alfredo. L’aprii e lessi: “Ho fatto le pulizie. Il pranzo te lo cucini da te, tanto ci sei abituato. Addio. Io torno da mamma. Agnese”. Per un momento non capii nulla. Poi rilessi la lettera e alla fine intesi: Agnese se ne era andata, mi aveva lasciato dopo due anni di matrimonio. Per forza di abitudine, riposi la lettera nel cassetto della credenza deve metto le bollette e la corrispondenza e sedetti su una seggiolina, presso la finestra. Non sapevo che pensare, non ci ero preparato e quasi non ci credevo. Mentre stavo così riflettendo, lo sguardo mi cadde sul pavimento e vidi una piccola piuma bianca che doveva essersi staccata dal piumino quando Agnese aveva spolverato. Raccolsi la piuma, aprii la finestra e la gettai di fuori. Quindi presi il cappello e uscii di casa.
Pur camminando, secondo un mio vizio, un lastrone sì e uno no del marciapiede, cominciai a domandarmi che cosa avessi potuto farle, ad Agnese, perché avesse a lasciarmi con tanta cattiveria, quasi con l’intenzione dello sfregio. Per prima cosa, pensai, vediamo se Agnese può rimproverarmi qualche tradimento, sia pure minimo. Subito mi risposi: nessuno. Già non ho mai avuto molto trasporto per le donne, non le capisco e non mi capiscono; ma dal giorno che mi sono sposato, si può dire che cessarono di esistere per me. A tal punto che Agnese stessa mi stuzzicava ogni tanto domandandomi: “Che cosa faresti se ti innamorassi di un’altra donna?”. E io rispondevo: “Non è possibile: amo te e questo sentimento durerà tutta la vita.” Adesso, ripensandoci, mi pareva di ricordarmi che quel “tutta la vita” non l’aveva rallegrata, al contrario: aveva fatto la faccia lunga e si era azzittita. Passando a tutt’altro ordine di idee, volli esaminare se, per caso, Agnese mi avesse lasciato per via di quattrini e, insomma, del trattamento che le facevo. Ma anche questa volta, mi accorsi che avevo la coscienza tranquilla. Soldi, è vero, non gliene davo che in via eccezionale, ma che bisogno aveva lei dei soldi? Ero sempre là io, pronto a pagare. E il trattamento, via, non era cattivo: giudicate un po’ voi. Il cinema due volte la settimana; al caffè due volte e non importava se prendeva il gelato o il semplice espresso; un paio di riviste illustrate al mese e il giornale tutti i giorni; d’inverno, magari, anche l’opera; d’estate la villeggiatura a Marino, in casa di mio padre. Questo per gli svaghi; venendo poi ai vestiti, ancora meno Agnese poteva lamentarsi. Quando le serviva qualche cosa, fosse un reggipetto o un paio di calze o un fazzoletto, io ero sempre pronto: andavo con lei per i negozi, sceglievo con lei l’articolo, pagavo senza fiatare. Lo stesso per le sarte e per le modiste; non c’è stata volta, quando lei mi diceva: “Ho bisogno di un cappello, ho bisogno di un vestito”, che io non rispondessi: “Andiamo, ti accompagno.” Del resto, bisogna riconoscere che Agnese non era esigente: dopo il primo anno cessò quasi del tutto di farsi dei vestiti. Anzi, ero io, adesso, a ricordarle che aveva bisogno di questo o quest’altro indumento. Ma lei mi rispondeva che ci aveva la roba dell’anno prima e che non importava; tanto che arrivai a pensare che, per quest’aspetto, fosse diversa dalle altre donne e non ci tenesse a vestirsi bene.
Dunque, affari di cuori e denari, no. Restava quello che gli avvocati chiamano incompatibilità di carattere. Ora mi domandai: che incompatibilità di carattere poteva esserci tra noi se in due anni una discussione, dico una sola, non c’era mai stata? Stavamo sempre insieme, se questa incompatibilità ci fosse stata, sarebbe venuta fuori. Ma Agnese non mi contraddiceva mai, anzi, si può dire, neppure parlava. Certe serate che passavamo al caffè o in casa, a malapena apriva bocca, parlavo sempre io. Non lo nego, mi piace parlare e sentirmi parlare, specie se sono con una persona con la quale sto in confidenza. Ho la voce calma, regolare, senza alti né bassi, ragionevole, fluida e, se affronto un argomento, lo sviscero da capo a fondo, in tutti i suoi aspetti. Gli argomenti, poi, che preferisco, sono quelli casalinghi: mi piace discorrere del prezzo della roba, della disposizione dei mobili, della cucina, del termosifone, insomma di ogni sciocchezza.
A parlare di queste cose non mi stancherei mai; ci provo tanto gusto che spesso mi accorgo che ricomincio da capo, con gli stessi ragionamenti. Ma, siamo giusti, con una donna questi sono i discorsi che ci vogliono: altrimenti di che cosa si deve parlare? Agnese, del resto, mi ascoltava con attenzione, almeno così mi pareva. Una sola volta, mentre le spiegavo il funzionamento dello scaldabagno elettrico, mi accorsi che si era addormentata. Le domandai, svegliandola: “Ma che, ti annoiavi?” Lei rispose subito: “No, no, ero stanca, questa notte non ho dormito.”
I mariti di solito hanno l’ufficio o il negozio o magari non hanno niente e se ne vanno a spasso con gli amici. Ma per me, il mio ufficio, il mio negozio, i miei amici erano Agnese. Non la lasciavo un momento sola, le stavo accanto perfino, forse stupirete, quando cucinava. Ho la passione della cucina e ogni giorno, prima dei pasti, mi infilavo un grembiule e aiutavo Agnese in cucina. Facevo di tutto un po’: pelavo le patate, capavo i fagiolini, preparavo il battuto, sorvegliavo le pentole. L’aiutavo tanto bene che lei, spesso, mi diceva: “Guarda, fa’ tu… ci ho mal di testa… vado a buttarmi sul letto.” E io allora cucinavo da solo; e con l’aiuto del libro di cucina, ero anche capace di provare dei piatti nuovi. Peccato che Agnese non fosse golosa; anzi negli ultimi tempi le era andato via l’appetito e sì e no toccava cibo. Una volta lei mi disse, così per scherzo: “Hai sbagliato a nascere uomo… tu sei una donna… anzi una massaia.” Debbo riconoscere che in questa frase c’era qualcosa di vero: infatti, oltre a cucinare, mi piace anche lavare, stirare, cucire e, magari, nelle ore di ozio, rifare gli orli a giorno dei fazzoletti. Come ho detto non la lasciavo mai: neppure quando veniva a trovarla qualche amica o la madre; neppure quando le saltò in capo, non so perché, di prendere lezioni d’inglese: pur di starle accanto, mi adattai anch’io a imparare quella lingua così difficile. Le ero tanto attaccato che qualche volta mi sentivo perfino ridicolo: come quel giorno che non avendo inteso una frase che lei mi aveva detto a bassa voce, in un caffè, la seguii fino ai gabinetti e l’inserviente mi fermò avvertendomi che era il reparto signore e io non ci potevo entrare. Eh, un marito come me non è facile trovarlo. Spesso, lei mi diceva: “Debbo andare nel tal posto, vedere la tal persona che non ti interessa.” Ma io le rispondevo: “Vengo anch’io… tanto non ci ho niente da fare.” Lei, allora, mi rispondeva: “Per me, vieni pure, ma ti avverto che ti annoierai.” E invece, no, non mi annoiavo e dopo glielo dicevo: “Hai visto: non mi sono annoiato.” Insomma, eravamo inseparabili.
Pensando queste cose e sempre domandandomi invano perché Agnese mi avesse lasciato, ero giunto al negozio di mio padre. È un negozio di oggetti sacri, dalle parti di piazza della Minerva. Mio padre è un uomo ancora giovane: capelli neri, ricciuti, baffi neri e, sotto questi baffi, un sorriso che non ho mai capito. Forse per l’abitudine di trattare coi preti e le persone devote, è dolce dolce, calmo, sempre di buone maniere. Ma la mamma che lo conosce dice che lui i nervi ce li ha tutti dentro. Dunque, passai tra tutte quelle vetrine piene di pianete e di ciborii e andai dritto al retrobottega dove lui ha la scrivania. Al solito, faceva i conti, mordendosi i baffi e riflettendo. Gli dissi, trafelato: “Papà, Agnese mi ha lasciato.”
Lui alzò gli occhi e mi parve che sotto i baffi sorridesse; ma forse fu un’impressione. Disse: “Mi rincresce, proprio mi rincresce… e come è stato?”
Gli raccontai come era andata la cosa. E conclusi: “Certo, mi dispiace… ma soprattutto vorrei sapere perché mi ha lasciato.”
Lui domandò, perplesso: “Non lo capisci?”
“No.”
Lui stette un momento zitto e poi disse con un sospiro: “Alfredo, mi rincresce ma non so che dirti… sei figlio mio, ti mantengo, ti voglio bene… ma alla moglie devi pensarci tu.”
“Sì, ma perché mi ha lasciato?”
Lui tentennò la testa: “Al tuo posto non approfondirei… lascia stare… che t’importa di sapere i motivi?”
“M’importa molto… più di tutto.”
In quel momento entrarono due preti; e mio padre si alzò e gli andò incontro dicendomi: “Torna più tardi… parleremo… adesso ci ho da fare.” Capii che da lui non potevo aspettarmi altro, ed uscii.
La casa della madre di Agnese non era lontana, in corso Vittorio. Pensai che la sola persona che potesse spiegarmi il mistero della sua partenza fosse proprio Agnese; e ci andai. Salii di corsa le scale, mi feci introdurre in salotto. Ma invece di Agnese venne la madre, una donna che non potevo soffrire, mercantessa anche lei, coi capelli neri tinti, le guance fiorite, sorridente, sorniona, falsa. Era in vestaglia, con una rosa sul petto. Disse, vedendomi, con finta cordialità: “Oh, Alfredo, come mai da queste parti?”
Risposi: “Lo sapete il perché, mamma. Agnese mi ha lasciato.”
Lei disse, calma: “Sì, è qui… figlio mio: che ci vuoi fare? sono cose che succedono.”
“Come, mi rispondete in questo modo?”
Lei mi considerò un momento e poi domandò: “Ai tuoi glielo hai detto?”
“Sì, a mio padre.”
“E lui che ha detto?”
Ma che cosa poteva importarle di sapere quel che avesse detto mio padre? Risposi malvolentieri: “Lo sapete com’è papà, lui dice che non debbo approfondire.”
“Ha detto bene, figlio mio… non approfondire.”
“Ma insomma”, dissi riscaldandomi, “perché mi ha lasciato? che le ho fatto? perché non me lo dite?”
Mentre parlavo, tutto arrabbiato, l’occhio mi cadde sopra il tavolo. Era ricoperto da un tappeto e sul tappeto c’era un centrino bianco ricamato e sul centrino un vaso pieno di garofani rossi. Ma il centrino era fuori posto. Meccanicamente, senza neppure sapere quel che facessi, mentre lei mi guardava sorridendo e non mi rispondeva, sollevai il vaso e rimisi il centrino a posto. Lei disse, allora: “Bravo… ora il centrino è proprio nel mezzo… io non me ne ero mai accorta, ma tu l’hai visto subito… bravo… e adesso è meglio che te ne vai, figlio mio.”
Si era alzata, intanto, e mi alzai anch’io. Avrei voluto domandare se potevo vedere Agnese, ma capii che era inutile; e poi temevo, se l’avessi vista, di perdere la testa, e fare o dire qualche sciocchezza. Così me ne andai e da quel giorno non ho più rivisto mia moglie. Forse un giorno lei tornerà, considerando che di mariti come me non se ne trovano tutti i giorni. Ma la soglia di casa mia non la passa se prima non mi spiega perché mi ha lasciato.